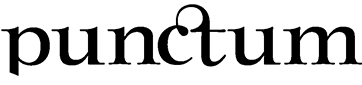La prima volta che ho visitato la Sardegna sono stato rapito. Ohh, che espressione infelice. L’isola in effetti ha una lunga storia di rapimenti veri e propri, con i suoi abitanti intenti a respingere gli invasori catalani, savoiardi, vandali e saraceni, puntando su un’arma che nessuna potenza straniera poteva possedere: la conoscenza di strade secondarie e dei luoghi in cui nascondersi. Io non ero stato rapito per ragioni politiche, piuttosto ero stato delicatamente raccolto dalla mia stanza nella American Academy di Roma dal mio nuovo amico, Luca Nostri, condotto in macchina nell’oscurità di gennaio a Civitavecchia, servito un bicchiere di mirto e messo a letto su una barca. Io e mia moglie ci sentimmo “rapiti” poiché non ci fu detto dove saremmo andati. Gli italiani eccellono nei rapporti sociali, così capaci di stare seduti per ore in un bar davanti a un caffè che richiede undici secondi per essere bevuto, parlando di qualunque cosa. D.H. Lawrence, descrivendo i ferrovieri in uniforme alla stazione di Messina, mentre si recava in Sardegna, scrisse: «A un funzionario italiano la vita sembra una lunga e animata conversazione». Il lavoro vero e proprio è secondario. «Sembrano api intorno all’alveare, che ronzano in una importante conversazione, e ogni tanto guardano questo o quel foglio di carta, ed estraggono un po’ di miele ufficiale. Ma è la conversazione l’avvenimento più importante». Trovo gli italiani quasi incapaci di descrivere il futuro. Così tanto piacere e ritualità sono dedicati al presente, che il futuro rimane remoto, un mormorio al di là di questo caffè, di questa conversazione.
Luca non ci rivelò mai dove fossimo diretti. Ci fu detto di preparare una valigia e che saremmo stati di ritorno dopo pochi giorni. Il traghetto ondeggiò e dondolò per otto ore. Non sono un marinaio. Anzi, mi viene la nausea già sui tapis roulant dell’aeroporto, quindi quando arrivai a Olbia avevo le viscere in subbuglio. E quando finalmente raggiungemmo Mamoiada, dopo interminabili tornanti (ideali per i rapitori), non le avevo più le viscere. Mi sentivo alla deriva, ricordo di aver vagato per le strade grigie e gocciolanti, non solo senza sapere cosa ci facessi lì, ma anche senza sapere chi fossi. Poi, dalla nebbia del primo mattino, uscirono uomini con maschere nere, coperti di pelli di pecora e decine di pesanti campane, che danzavano, impassibili, e che saltando simultaneamente creavano un ritmo incapacitante. Si manifestarono in una piccola piazza irregolare di cemento grigio e umido e ballarono avanti e indietro con movimenti così estranei al ritmo domestico e distinto di qualsiasi paese di montagna del Mediterraneo, che sembravano pulsazioni di morte, che scatenavano un terrore medievale. Provengo da piccoli paesi dell’upstate New York e del Massachusetts. Avremo avuto anche noi processi alle streghe e cavalieri senza testa, ma per lo più la nostra mitologia rimane nei margini. Era spesso difficile credere ai miei occhi. Il mio delirio era poi favorito dalle dozzine di bicchieri di vino fatto in casa che ogni nonnina mi versava (mi era stato spiegato sarebbe stato scortese rifiutare). Quando infine fummo spinti attraverso una porta d’acciaio nel cortile di una famiglia, dove lo stomaco di una pecora veniva modellato in un calderone di sangue bollente, rinunciai a cercare di ricordare il mondo precedente a quel momento e cedetti alla visione. Qualsiasi cosa avessi di fronte, era ciò che era.
Quando avevo sedici anni, entrai in un edificio col telaio ad A rivestito in abete di Douglas nella campagna del New England, per prendere parte alla First Church of Fun. Si trattava di un evento di assunzione di LSD organizzato da un burlone psichedelico di nome John Dwork. La casa era cablata per il suono e illuminata con ogni sorta di strani effetti. L’LSD liquido di alta qualità che avevano portato si era rovesciato su un tovagliolo di carta, quindi nessuno sapeva esattamente quanto ne avremmo assunto. Masticai il mio quadratino di Bounty da due pollici e aspettai che succedesse qualcosa. La cosa successiva che ricordo davvero è il risveglio a casa di un mio amico in città, avvolto in un lenzuolo. Nei mesi successivi (e ancora oggi) ho ricostruito quello che era successo, sentendomi vuoto, non vuoto spiritualmente, ma raschiato, come un barattolo di marmellata. C’era stato qualcosa che aveva a che fare con il guardarsi allo specchio (un errore da psiconauta alle prime armi). Poi c’era stata una parte in cui se avessi invertito tutte le mie funzioni corporee, sarei diventato il messia. Seguì un po’ di riordine. Secondo il mio amico, a un certo punto mi avvicinai allo sciamano principale e annunciai: «Io sono Dio. Tu sei l’universo» e lo morsi con forza, facendo uscire il sangue. Per circa due settimane, guidai per un New England grigio e senza fondo, ascoltando la colonna sonora del film Paris, Texas su una cassetta tremolante, senza essere sicuro di cosa fosse cosa.
Non ho mai più preso l’LSD. E non ho mai smesso di sapere che nulla è ciò che sembra. Quando i critici iniziano a spremersi le meningi domandandosi se le fotografie siano reali e cosa debbano al mondo per le loro rappresentazioni della verità, faccio il mio miglior sorriso di circostanza, alzo il sopracciglio sinistro e aspetto che la conversazione finisca, come a una cena con parenti vagamente fascisti durante una festività. Non è possibile che qualcosa sia veramente vero. Quello che vedete voi e quello che vedo io sono due cose diverse. Ciò che vedete lasciando che i movimenti saccadici dei vostri occhi interrompano la catena di messa a fuoco è diverso da un millisecondo all’altro. Guardate la foto sul vostro passaporto. Siete voi? Il voi che stava lì nello studio di quel fotografo (magari nel retro di una farmacia) è lo stesso che si è svegliato questa mattina tra le braccia del suo amante, anni dopo? D’altra parte, è nella natura della macchina fotografica credere completamente a qualsiasi cosa le si presenti davanti. La fotocamera si vota totalmente a qualunque religione le venga istruita, si innamora perdutamente del bel ragazzo che sta camminando per strada in questo momento, senza curarsi degli ultimi trentacinque passati precedentemente. Tutto ciò che la fotocamera vede è un’allucinazione, che sovrascrive e supera tutto ciò che è venuto prima. E ogni fotografo è alla ricerca di quell’allucinazione, di quella sensazione che il flusso e lo scorrere del mondo possano balzare in una cornice e annunciare di avere un significato importante. La fotografa si ferma improvvisamente sulla strada, con lo sguardo rivolto a qualcosa che non riuscite a vedere. Si inginocchia sul terreno bagnato e osserva una pozzanghera. Non riesce a smettere di fissare uno svolazzo lontano tra gli alberi. Forse è una gazza.
La terza volta che ho visitato la Sardegna, non avevo lasciato il mio Paese in due anni di blocco per la pandemia. Ho attraversato l’oceano con una mascherina così scomoda che nessun Ambien avrebbe potuto stordirmi. Dopo tanti mesi in cui avevo visto persone solo all’esterno, mi sentivo come una sardina che abbandona intenzionalmente la sua famiglia per una lattina angusta e oleosa. Mi portarono a Gavoi, in un albergo completamente vuoto vicino al lago di Gusana, e mentre mi sdraiavo per cercare di dormire, la stanza cominciò a rimbombare. La Sardegna, avevo letto, è un luogo “senza terremoti”, così mi precipitai sul balcone, solo per vedere un enorme aereo giallo che si abbassava verso il lago con la delicatezza di una bolla di sapone. L’aereo ha sfiorato la superficie del lago, ha raccolto un carico d’acqua e si è alzato di nuovo in volo, rilasciandola in un vago spruzzo. Ero distrutto per non averlo fotografato, ma l’aereo ha girato intorno per un altro tentativo, e l’ha fatto ancora e ancora. Insonnolito, ma certo che non avrei avuto problemi ad avere allucinazioni attraverso la Sardegna, ho percorso i cinque tortuosi chilometri fino a Gavoi e al The Photo Solstice, dove ho incontrato gli studenti che avrei visto aprire i loro primi, secondi e terzi occhi al potere allucinatorio delle immagini impossibili di questa terra magica»