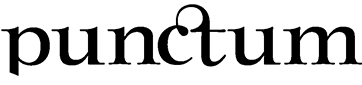A prima vista lo si direbbe un fotomontaggio. Ben pensato e altrettanto ben realizzato; sebbene, forse, con qualche accento didascalico di troppo. Si riconosce bene, nella foto, l’icona del potere che è il grande palazzo della Farnesina, i cui lavori iniziarono nel ’37 e vennero ultimati più di vent’anni dopo. Milletrecento stanze e settecentomila metri cubi di travertino torreggiano lontani e indifferenti, schiacciando un primo piano di desolazione e miseria, mattoni a giorno e panni stesi in una qualunque favela del Sud del mondo.
Un effetto retorico simile userà Pasolini nel famigerato epigramma A un Papa (poi nella Religione del mio tempo) che, uscito su «Officina» nel febbraio del ’59, finì per causare la chiusura della rivista da parte di Bompiani che l’aveva appena rilevata. A illustrare in forma d’emblema le vite parallele del Sommo Pontefice Pio XII, appena spirato nel suo letto principesco, e di un vecchio «ragazzaccio plebeo» travolto da un tram mentre dormiva all’addiaccio, Pasolini vi accosta artificialmente San Pietro a San Paolo, nei cui pressi si trovano i Mercati Generali dove aveva trovato rifugio il barbone; mentre a Roma le due chiese, in effetti, sono ben
distanti fra loro. La sovrimpressione dei versi finge invece che la morte del «povero Zucchetto» si sia consumata all’ombra del Vaticano incurante: «Ci sono posti infami, dove madri e bambini / vivono in una polvere antica, in un fango d’altre epoche» (in effetti non lontano dalla «bella cupola di San Pietro» c’era allora «uno di questi posti, il Gelsomino… / Un monte tagliato a metà da una cava, e sotto, / tra una marana e una fila di nuovi palazzi, / un mucchio di misere costruzioni, non
case ma porcili»).
[…] Andrea Cortellessa, Campi. Continua a leggere su: Pasolini, Ipotesi di Raffigurazione