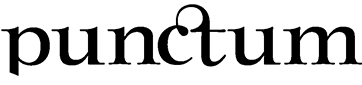[:it]A cura di Marco Delogu e Flavio Scollo
8 novembre – 26 dicembre 2017
MACRO, Via Nizza 138, Roma
Guy Tillim (Johannesburg, 1962) è un fotografo sud-africano principalmente conosciuto per i suoi lavori incentrati sulle regioni turbolenti dell’Africa sub-sahariana e che molta attenzione ha dedicato a Johannesburg e le sue tensioni, città di cui è originario.
Inizia la sua carriera di fotogiornalista come membro dell’Afrapix, un collettivo di fotografi che si opponeva apertamente all’Apartheid in Sud Africa e al quale rimarrà legato fino al suo scioglimento nel 1991. Successivamente continuerà a lavorare come freelance con numerose agenzie tra cui Reuters e Agence France Presse. Anche grazie al supporto della galleria Stevenson, il suo lavoro prende gradualmente sempre più le distanze dal fotogiornalismo classico e si indirizza verso una visione più personale e segnata da un’autorialità forte e vicina al mondo dell’arte contemporanea, pur sempre rimanendo molto legato ai temi sociali ed in particolare alle realtà contemporanee africane ed al suo passato coloniale.
Nel 2007 partecipa infatti a documenta (una delle più importanti manifestazioni d’arte contemporanea) a Kassel esponendo il lavoro Congo Democratic. Con la Commissione Roma del 2009, dove realizza il primo lavoro fuori dai confini africani, Roma città di mezzo, identifica uno dei punti di svolta nel modo di approcciarsi alla fotografia. Seguiranno poi altri lavori al di fuori del continente africano, tra i quali i luoghi visitati nella serie Second Nature, e che lo confermeranno sempre di più come uno degli esempi più noti tra gli autori che dal fotogiornalismo sono riusciti a sviluppare un proprio linguaggio con successo al di là dei confini del mondo dell’editoria ed anzi sdoganandosi completamente da esso.
Joburg: Points of View del 2013 è uno dei casi interni alla carriera di Tillim tra i più esemplari nel testimoniare l’evoluzione del suo linguaggio: i dittici ambientati nella quotidianità delle strade di Johannesburg creano una finestra sulla città che induce lo spettatore a sospendere il giudizio e a indagare lo spazio osservato, ottenendo una visione che al tempo stesso si oppone e si completa con la Jo’burg (2004) di quasi dieci anni prima, una città claustrofobica segnata dalle tensioni e dagli sfratti negli appartamenti popolari.
Da questo nuovo approccio prende vita anche il suo ultimo progetto, con cui è vincitore del prestigioso HCB Award istituito dalla Fondation Henri Cartier-Bresson, Museum of the Revolution (2017), dove indaga i paradossi e le contraddizioni dei paesi post-colonialisti attraverso le sue strade, strutturate secondo i capricci delle potenze coloniali e testimoni silenti dei cambiamenti politici, e che oggi riflettono una realtà di ricostruzione e di nuove aspirazioni imbevute di valori capitalistici.
Museum of the Revolution chiude anche la mostra O Futuro Certo, che nel suo allestimento si propone di guidare lo spettatore all’interno della vasta produzione di Tillim attraverso i suoi lavori più importanti, posti in un dialogo continuo tra loro e dove, in un percorso ideale di continui rimandi, il racconto del mondo (e in particolare dell’Africa) viaggia in parallelo con il mutare della visione autoriale dell’artista.
8 November- 26 December 2017
MACRO, Via Nizza 138, Roma
Why this exhibition? The truth is, I don’t really know. I could go ahead and explain myself, describe the context of the images, but it would be like building a wall to describe a field of meaning. What I find interesting in images defies a literary code, its vocabulary lies elsewhere. Perhaps it is musical. You have to look at it, listen to it, and therein lies the paradox.
What is exchanged in photography is often stereotype, each successful image is in part a resistance to that impulse alone. Easy to make, but if it does not speak directly of a deep experience of the world, it is nothing much. Experience of the world that is rich, nuanced, detailed, ambiguous, is reduced to signifiers that confirm how I’d like it be. I look at the photographs I have made and they are such pale echoes of an experience. Let them be ambiguous, un-emphatic, that is enough for now.
I will not deny the photograph’s ability to witness, to people the past, to chronicle events, but to me photography has strained to penetrate the mansions of memory. My own childhood is like a dream, others inhabit it as if in a dream, they cannot know it. We will agree on the documentary evidence available that it existed, certain things happened, and the photographs will be the pillars of a myth that will float in an impenetrable haze of oblivion.
I have come to be convinced that photographs are impartial, or should strive to be. Their objectivity, despite the subjectivity of seeing, or indifference to certitude is their achievement, if any. If they have a partisanship it should lie with a scene seeking an audience, not with who’s looking at it. So in making photographs I try to frame a window onto a world that in its way looks back through me or my camera and asks the simple question always worth asking: who am I? I humour myself and think that these photographs are steps towards that window.
Guy Tillim